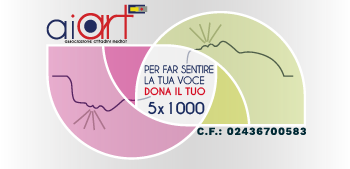Riforma televisiva e pubblicità
Il presente saggio,di Adriano Zanacchi docente alla facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università Pontificia salesiana di Roma, fornisce un’importante visione generale su come il sistema mediatico, la tv in particolare, stia diventando sempre più strumento centrale dell’organizzazione del potere. Dal n. 37 di gennaio 2016 della rivista trimestrale dell’Aiart La Parabola.
![]() Adriano Zanacchi – Riforma televisiva e pubblicità
Adriano Zanacchi – Riforma televisiva e pubblicità
RIFORMA TELEVISIVA E PUBBLICITA’
di Adriano Zanacchi
La discussione sull’egemonia culturale della televisione si trascina da decenni ed è destinata a durare all’infinito. Nonostante i radicali cambiamenti che sono avvenuti nel sistema della comunicazione, la televisione occupa sempre un ruolo centrale tra le fonti in grado di influenzare l’opinione pubblica e, più in generale, la mentalità collettiva. I nuovi media convivono con quelli “vecchi”, ma la televisione «in Italia continua a essere il mezzo di informazione prevalente», vero e proprio “luogo di incontro della cultura popolare”.
E’ quindi naturale – e doveroso – che nello strisciante dibattito sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e sulla regolamentazione complessiva del sistema televisivo abbia un posto rilevante il problema della funzione informativa. Se ne discute dagli anni settanta del secolo scorso, quando la prima “riforma” della Rai fece segnare il passaggio del controllo del servizio pubblico e della società concessionaria dal Governo al Parlamento. Con risultati del tutto deludenti, perché inadatto ad assicurare l’indipendenza dell’informazione Rai, confermandone la sudditanza politica. Una sudditanza confermata dalla discussa riforma della Rai del dicembre 2015 secondo la quale la nomina dell’amministratore delegato, con pieni poteri, è affidata al Governo.
Si è subito osservato che questa riforma segna il ritorno a prima del 1975, a una Rai dipendente dal potere politico, tanto da mettere in gioco il pluralismo e la libertà di informazione del servizio radiotelevisivo pubblico.
Ma al di là dell’influenza che può essere attribuita alle trasmissioni informative esiste, altrettanto rilevante, il ruolo che l’intera programmazione televisiva può esercitare, più in generale, sul costume, sulla mentalità, sulla cultura. Si tratta, peraltro, di un tema che sembra sfuggire a quanti si occupano dei problemi del sistema televisivo nel suo insieme. Se è vero, infatti, che l’informazione, nelle sue varie forme, può incidere sull’orientamento politico e sulle scelte elettorali dei telespettatori, è anche vero che l’intera programmazione può condizionare più in profondità il loro modo di pensare e di essere, con conseguenze in grado di ricadere, a breve o a lungo termine, anche nell’ambito politico; e che, comunque, l’influenza della televisione non costituisce un problema unicamente politico.
Non si tratta, naturalmente, di sostenere l’onnipotenza incondizionata del mezzo, ma del ruolo che esso esercita tra tutte le fonti che incidono sull’educazione, sui rapporti sociali, sulla cultura. Non sono in discussione, quindi, le sole trasmissioni di natura informativa, ma tutti i contenuti dei programmi televisivi e la loro possibile influenza.
I poteri della televisione
Il tema dei possibili effetti, positivi e negativi, della televisione costituisce, da sempre, una questione assai complessa e dibattuta. E resta sempre aperto. Sin dalle prime indagini sulla violenza televisiva, con particolare riguardo ai minori, che erano state precedute dalle osservazioni sulle possibili influenze negative di film e radiodrammi sul pubblico dei giovani, gli studi sugli effetti o sui “poteri” dei media si sono poi allargati e intensificati, specialmente con riferimento ai contenuti televisivi violenti e, successivamente, all’influenza dei media sui processi di costruzione della realtà sociale.
E’ convinzione diffusa tra gli studiosi che i media non siano in grado di determinare, si può dire meccanicamente, le opinioni dei telespettatori, ma “solo” di scegliere (e di imporre?) i temi intorno a cui avere opinioni, di stabilire, quindi, l’elenco di ciò che è importante. Si parla, in proposito di “effetto agenda” (teoria dell’“agenda setting”), cioè della capacità dei media di proporre (e di imporre?) argomenti, problemi, protagonisti, attraverso una serie di operazioni di “agenda building”: interventi che guidano la selezione e le decisioni concrete riguardanti i contenuti diffusi. Si afferma così che, in conseguenza dell’azione esercitata dai media, delle loro scelte e delle loro proposte, il pubblico diviene consapevole o ignora, presta attenzione oppure trascura, enfatizza o abbandona, elementi, fatti, avvenimenti e protagonisti della scena pubblica e tende a includere o a escludere dalle proprie conoscenze ciò che i media includono o escludono dai propri contenuti. Gli individui finiscono così per mutuare dai media la comprensione della realtà sociale e per riflettere l’ordine di importanza degli eventi, dei problemi, delle persone proposte dai media. Ma la “costruzione dell’agenda” in base a quali criteri viene compiuta?
Uno sguardo anche superficiale alla programmazione televisiva consente di constatare quanta parte abbia la violenza nei programmi di intrattenimento. E, come era già accaduto per la radio e il cinema, la preoccupazione per le conseguenze della violenza proposta in televisione rimane il tema di maggiore interesse, di fronte ad una programmazione che si avvale oggi di centinaia, se non di migliaia di canali. Ma perché c’è molta violenza nella programmazione televisiva? La domanda si pone anche per altri contenuti considerati negativi delle trasmissioni, dalla volgarità alle banalità alla cronaca nera. I media operano continue selezioni e una riduzione inevitabile della realtà, quindi una sua deformazione, che può avere conseguenze sulla sfera cognitiva, valutativa e affettiva degli individui.
Sulla base di tali selezioni e riduzioni, ciascun membro del pubblico costruisce il proprio sapere, spesso ignorando chi effettivamente manovra le leve dei media. Che propongono continuamente immagini, concezioni, rappresentazioni della realtà, fenomeni designati da Gianni Losito come “rappresentazioni” in grado di semplificare la realtà o un suo determinato aspetto. Esse svolgono una duplice funzione: «consentire l’interpretazione della realtà e anche orientare il comportamento individuale e collettivo, coinvolgendo la dimensione cognitiva e quella valoriale e normativa».
Si delinea, in tal modo, il meccanismo di influenza dei media che dovrebbe costituire un tema fondamentale per chi affronta l’annoso e complesso problema della riforma del sistema televisivo, che non può essere certo affrontato a cuor leggero o semplicemente ridotto a quello dell’imparzialità politica nelle nomine dirigenziali del servizio pubblico.
Oggi, come si è visto, appare ampiamente condivisa dagli studiosi della comunicazione di massa la convinzione che l’influenza dei media non sia assoluta, ma condizionata da una molteplicità di fattori personali e sociali. Non siamo certo di fronte a mezzi onnipotenti, anche se il loro “potere” appare tanto più forte quanto più deboli sono gli altri fattori di mediazione, a partire dalla crescente debolezza della formazione familiare e di quella operata dalle altre agenzie educative. Un potere strettamente legato (anche) ai contenuti diffusi, spesso accusati di privilegiare non solo la violenza, ma anche atteggiamenti e comportamenti antisociali.
Si tratta di un’accusa che si trascina ormai da tempo e che chiama in causa, pesantemente, quella che viene comunemente definita come la tirannia degli indici di ascolto, direttamente legata alla dimensione economica della realtà televisiva, come dei media in generale, e al ruolo della pubblicità quale fonte di finanziamento ( e/o di profitto), parziale o totale, delle emittenti. Un fattore del sistema che spinge la programmazione verso i richiami più spregiudicati, non solo la violenza in tutte le sue dimensioni, ma anche lo sfruttamento volgare della sessualità, del pettegolezzo, di ogni forma di trasgressione. Losito parla, in proposito, di gravissime colpe dei media: «Non solo violenza, non solo propaganda politica urlata, sregolata o surrettizia, non solo l’ossequioso allineamento o la preconcetta contrapposizione, ma anche l’asservimento alle routine produttive, la crisi della professionalità, la caduta della qualità, l’offesa, sempre più frequente, al buon senso e all’intelligenza del pubblico».
Lo stesso studioso ricorda l’importanza che assumono i media nell’influenzare il processo di socializzazione, «attraverso cui ogni attore sociale apprende quanto è richiesto per vivere in una data società e in un determinato momento storico, dai modi di comunicare alle conoscenze, dai valori alle norme sociali, dagli atteggiamenti alle rappresentazioni sociali, dalle prerogative di status alle aspettative di suolo e così via». I media, infatti, «propongono in modo sia esplicito sia implicito conoscenze, opinioni, atteggiamenti, modelli di comportamento, valori che contribuiscono a determinare il vissuto delle persone, vissuto che a sua volta interviene nella formazione e nel cambiamento di opinioni, atteggiamenti e comportamenti». Si può dire, pertanto, che la televisione, come gli altri media, può agire in senso pro-sociale o anti-sociale, sia pure con la difficoltà di stabilire in modo condiviso ciò che corrisponda a questi due possibili orientamenti.
E’ alla luce di queste incertezze che dovrebbe essere considerato il ruolo svolto dalla pubblicità come fattore che incide profondamente, condizionandola, sull’intera programmazione, se si vuole comprendere nel suo insieme la possibile influenza esercitata dal mezzo televisivo. Non solamente, quindi, con riferimento alla correttezza delle trasmissioni giornalistiche.
Per restare al ruolo informativo della programmazione televisiva e al venir meno della sua più o meno relativa imparzialità, del resto, basterebbe ricordare il fenomeno dei talk show, che dovrebbero costituire una palestra di informazione e di confronto utili per la formazione ottimale dell’opinione pubblica, e che invece si trasformano, generalmente, in sovrapposizioni di voci, di scontri violenti e volgari con la complicità di “conduttori” che invece di puntare su confronti pacati ed esaurienti, sono ossessionati, si può dire, dagli indici di ascolto. Perché sono questi indici, a loro volta legati a filo doppio agli introiti pubblicitari, a determinare la “bontà” di qualsiasi programma,. Così che a “discorrere” si invitano persone o personaggi discussi o chiacchierati, petulanti, predisposti alla provocazione, alla violenza verbale, al litigio, alla prepotenza.
Ci troviamo di fronte al micidiale meccanismo economico che caratterizza la vita della televisione, come di tutti gli altri mezzi di comunicazione, e che risulta condizionante sui contenuti diffusi e, quindi, sulle loro possibili conseguenze: quello della pubblicità quale forza di pressione sull’orientamento gestionale e dell’intera programmazione. Fino a riversarsi sulla stessa funzione informativa che, magari resa indenne (nelle intenzioni!) da condizionamenti di parte, può finire per essere coinvolta, con tutto l’insieme delle trasmissioni, in un’azione di inquinamento a senso unico, dovuto al prevalere dell’effetto-richiamo sulla correttezza informativa. Come dimostra, appunto, l’esempio dei talk show.
L’indipendenza della televisione del servizio pubblico (ma vedremo che il problema riguarda seriamente anche la stessa televisione commerciale) rappresenta solo un aspetto della riforma, ove di vera indipendenza – quindi di rispetto per i cittadini – si intenda parlare. Se è vero, infatti, che i telegiornali e le altre trasmissioni giornalistiche possono condizionare gli orientamenti politici e le decisioni di voto, è anche plausibile ritenere che su di essi possa influire l’insieme dell’offerta televisiva. Ma è bene ribadire che le preoccupazioni relative all’influenza esercitata dalla televisione non possono ridursi al solo ambito politico-elettorale.
Il quadro desolante della programmazione
Nonostante la mole di ricerche sugli effetti dei media, come si è visto, non avremo mai prove certe della loro influenza, elettorale e non. A partire da quella esercitata dalle trasmissioni di attualità. Ciò vale anche per le possibili incidenze sul costume dovute ai contenuti non strettamente giornalistici, che a loro volta possono condizionare sia l’espressione del voto (o del non voto) dei cittadini sia, più in generale, il loro modo di pensare e di vivere.
Ma a farci “sospettare”, anzi a credere, che la televisione incida su abitudini e stili di vita, come ha scritto Ernesto Galli Della Loggia, ci sono «la nostra percezione, viva, quotidiana; e la nostra intelligenza. […] Per mille segni avvertiamo intorno a noi, infatti, che ogni giorno il senso della vita delle persone che abitano questo Paese, l’orizzonte dei loro sentimenti e delle loro emozioni, il loro rapporto con il passato, sono sottilmente ma ineluttabilmente distorti, svuotati, manipolati, corrosi, e poi ricombinati in modo nuovo dalla televisione».
Secondo Della Loggia «è nello spazio strabordante dei programmi d’intrattenimento che soprattutto si compie la manipolazione distruttiva dell’antropologia italiana. In quei programmi dove – pur senza arrivare ai livelli postribolari di cose come L’isola dei famosi o del Grande Fratello – si mischiano presentatori-guitti, comicastri, sound triviali, corpi seminudi, trovate quizzistiche da quattro soldi e torrenti di chiacchiere sul nulla. E’ da questa poltiglia che colano ininterrottamente dalla mattina alla sera nella testa di milioni di italiani modelli di comportamento posticci e spregevoli, disprezzo implicito per ciò che è intelligente e frutto di tecnica e di sacrificio, l’idolatria dell’apparire, l’ammirazione per tutto ciò che è esagerato, sgangherato, enfatico, superfluo, ai danni di ciò che invece è normale e appropriato».
E’ vero che Galli Della Loggia non è propriamente un massmediologo, ma non vi è studioso dei media che sia in grado di contestare seriamente le sue affermazioni, così come non vi è nessuno, tra quanti si occupano della regolamentazione del sistema televisivo, che si preoccupi di approfondire l’esame del quadro da lui descritto, come premessa per ogni discorso sulla riforma di cui si continua a parlare, che si domandi come e perché «la poltiglia televisiva costituisce il surrogato dell’egemonia culturale sulla società italiana che le sue classi dirigenti non sono più capaci non dico di esercitare ma neppure di immaginare».
Il desolante quadro tracciato da Galli della Loggia non è che la sintesi di una infinità di accuse che si sono da tempo accumulate nei confronti della programmazione televisiva, della sua degradata realtà. Come ha scritto Luca Borgomeo su questa rivista, «La tv, tutta la tv, anche quella pubblica (nei fatti, eterodiretta dal colosso mediatico-economico-politico berlusconiano), ha riversato nelle case degli italiani vagonate di programmi insulsi, volgari, sciatti – conditi quasi sempre di sesso, volgarità, banalità e scurrilità – spesso immorali o amorali, quasi sempre offensivi della dignità e identità culturale dei telespettatori.[…] Credo che nessuno possa contestare che la tv ha inquinato la vita di un’intera comunità, veicolando messaggi che minano la convivenza civile».
Anche Borgomeo ha indicato, tra i programmi emblematici della “devastazione delle coscienze”, L’isola dei famosi e Il Grande Fratello. Sull’impatto di quest’ultima trasmissione basterà riportare il recente resoconto sintetico, pubblicato dal “Corriere della Sera” del 12 dicembre 2015, relativo all’ultima edizione:
«Con la vittoria di Federica Lepanto, si è conclusa giovedì scorso l’edizione numero 14 del “Grande Fratello”. La serata finale del reality ha registrato un boom di ascolti: oltre 4 milioni e 300mila spettatori, pari al 22% di share, sono rimasti incollati ai teleschermi, consegnando al reality di Canale 5 lo scettro di programma più visto della serata. Il boom di ascolti è stato accolto dal direttore dell’ammiraglia Mediaset Giancarlo Scheri con soddisfazione. In una nota, Scheri ha evidenziato che “la media d’ascolto di quest’anno è stata del 19% di share con oltre 3.500.000 telespettatori”, sottolineando il successo del programma anche sul fronte dei social grazie alla “capacità di essere multipiattaforma, perfetto per la televisione moderna”. Dopo 15 anni, è stato invece il commento del presidente di Endemol Italia, Paolo Bassetti, il format “Grande Fratello” centra ancora l’obiettivo con successo e continua a essere un format di grande richiamo con una forte presa sui giovani, di cui ha saputo intercettare percentuali altissime”».
Dunque, una trasmissione additata come esempio, a dir poco, di poltiglia televisiva, viene ormai considerata un successo per il semplice fatto di avere “intercettato” percentuali altissime di giovani anche grazie al contributo dei social, quindi “programma perfetto per la televisione moderna”. Programma perfetto, in termini commerciali, per attirare e diffondere messaggi pubblicitari: una combinazione esemplare della concezione corrente del mezzo televisivo.
Se non che, la preoccupazione dei riformatori del sistema Tv sembra circoscritta, come si è detto, all’influenza politica della programmazione, mentre l’effetto devastante della programmazione nel suo insieme sotto il profilo educativo e, più ampiamente, culturale non sembra sfiorare i loro pensieri, benché tale negativo impatto culturale costituisca il viatico per un declino complessivo del tessuto sociale, in grado di trascinare in un baratro anche la dimensione politica. Ma i protagonisti del dibattito sulla riforma della Tv non sembrano interessarsi di ciò che i critici televisivi scrivono da tempo. Mi limito a una sola citazione, che risale ormai a parecchi anni fa, ma che ben si applica al quadro corrente della programmazione: «La tv deve confrontarsi etimologicamente con la volgarità: l’indice d’ascolto infatti è la sola misura della sua divulgazione, tiene desta costantemente la sua vocazione triviale; la sua missione è di soddisfare i gusti più corrivi del pubblico in una sorta di gratificazione continua». Così scriveva Aldo Grasso, non solo critico televisivo, ma anche studioso dei media, sul “Corriere della Sera” del 30 dicembre 2002, sotto il titolo eloquente “Tv maestra di volgarità”.
Già nel 2008, del resto, lo stesso Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò, aveva rilevato che «la televisione italiana presenta livelli di banalità e volgarità (come i tanti reality che affollano i palinsesti delle tv in prima serata) che la collocano al di sotto di altre televisioni europee». Banalità e volgarità che, purtroppo, non riguardano solo i reality, ma inquinano, si può dire, quasi tutti i generi di trasmissione.
Siamo di fronte a un quadro aberrante che induce a richiamare il potere di influenza della televisione con le parole di Marino Livolsi, autorevole studioso dei media: «Nell’insieme, i contenuti televisivi e il modo in cui essi sono proposti possono essere considerati la matrice di fondo della costruzione dell’identità (identity-framing) individuale e collettiva. Tutto quanto appare in televisione è un insieme di suggestioni, di suggerimenti e di stimoli che vengono utilizzati da ogni spettatore per costruire il senso e il significato da dare alla propria vita e per avere un’immagine del mondo e del luogo che ognuno vi occupa, ma anche per avere idee sul modo di presentarsi agli altri come vorremmo o presumiamo che gli altri si aspettano che noi siamo».
La comunicazione televisiva
Ormai da tempo «viviamo in un contesto culturale nel quale la comunicazione di conoscenze, significati, valori, interpretazioni, giudizi, modelli di vita avviene non solo sulla base di rapporti diretti interpersonali, ma sempre più a partire da incontri mediati da sistemi tecnologici di comunicazione». Se consideriamo la realtà televisiva, specialmente quella di casa nostra, dobbiamo amaramente constatarne l’immane degrado, ormai documentato da una mole impressionante di denunce, delle quali le tre poco sopra citate non sono che un piccolissimo “campione”, per quanto significativo oltre che autorevole. Si potrebbe affermare che il mezzo televisivo ha tradito nel modo peggiore ogni potenzialità di promozione sociale, politica, culturale che il suo linguaggio e la sua diffusione gli permetterebbero.
Nel valutare meriti e demeriti della televisione, occorre ricordare che si tratta di un mezzo di comunicazione che premia, forse più di ogni altro, l’emotività rispetto alla razionalità, non aiuta la riflessione, favorendo la passività, e suscita emozioni senza offrire un aiuto a viverle con profitto, ad approfondire i temi proposti, facendo prevalere le percezioni sulla comprensione della realtà. Non c’è quindi da meravigliarsi, ad esempio, se oggi l’autostima non nasce (più) dal compiere il proprio dovere – a scuola, in famiglia, sul lavoro, in politica – ma dall’apparire, dal narcisismo, dalla continua ricerca dell’emozione, dalla competizione fine a se stessa, dal successo ottenuto non importa come.
Il distacco tra apparenza e realtà si fa sempre più profondo. Riferendosi alle ricerche compiute per misurare le percezioni su aspetti sociali, demografici ed economici in 14 Paesi, Nando Pagnoncelli si è così espresso in proposito: «Aggregando le discrepanze tra percezione e realtà tra tutte le domande, abbiamo creato un “indice di ignoranza” che classifica i Paesi dal meno al più informato. L’Italia conquista il dubbio primato, seguita da Stati Uniti e Corea del Sud, mentre i più informati sono tedeschi e svedesi». Eppure «sono le percezioni che guidano le nostre opinioni e i nostri comportamenti. Non a caso la distanza tra percezioni e realtà può far comodo alla politica e ai media: alla politica per cavalcare gli allarmi sociali ai fini del consenso, ai media per aumentare l’audience».
Questi rilievi inducono a confermare che la cattura dell’audience costituisce l’obiettivo fondamentale del sistema televisivo – e più in generale, dei media – direttamente connesso con il ruolo esercitato dalla pubblicità, che non è solo fonte di finanziamento, ma è anche fonte di condizionamento della programmazione. La stessa informazione, pur nell’ipotesi di una sua ipotizzabile indipendenza politica, finisce per ubbidire alla “legge” concorrenziale del richiamo, che porta a privilegiare fatti e problemi capaci di esercitare una carica emotiva elevata, a catturare l’ascolto con ogni mezzo. Quindi una comunicazione a senso unico, guidata implacabilmente dall’imperativo del profitto economico.
Ma se nel dibattito sulla regolamentazione della Rai (e dell’intero sistema televisivo) si pone l’accento sull’indipendenza politica, nulla o molto poco si dice sulla deformazione che tale profitto finisce per orientare nel suo insieme la programmazione, con ricadute che riguardano anche le scelte politiche dei cittadini. Una televisione asservita alla servitù pubblicitaria non è una televisione democratica: è un mezzo al soldo di finalità economiche di parte, in grado di coinvolgere, al peggio, anche le istanze politiche. Quanto all’indipendenza politica non bisogna poi dimenticare l’irrisolto problema del conflitto di interessi che ha consentito e tuttora consente a un leader politico di condizionare l’informazione attraverso il possesso e l’esercizio di tre reti televisive, che si sono affermate nell’universo dell’emittenza attraverso una legislazione di favore. Sul conflitto di interessi, come ha affermato recentemente il Presidente del Senato Piero Grasso, “siamo oltre ogni ragionevole ritardo” e “una legge chiara metterebbe le istituzioni al riparo da possibili rischi di abuso e legherebbe i politici a responsabilità precise e non a polemiche talvolta strumentali”.
La pubblicità come cardine del sistema
Il sistema dei media, e della televisione in particolare, si regge dunque sulla pubblicità, che ne costituisce la fonte, unica o comunque fondamentale, di finanziamento e/o di profitto. Ed è proprio la pubblicità che ci offre una illuminazione empirica sugli effetti del mezzo (dei mezzi): se, infatti, le imprese investono cifre ingenti per l’acquisto degli spazi commerciali, vuol dire che il loro messaggi “funzionano”, anche se non esiste un sistema in grado di provare con un sufficiente grado di certezza gli effetti ottenuti. La “misurazione” dell’efficacia pubblicitaria resta sempre problematica, ma il “ritorno” è generalmente una realtà. Il che conferma, sia pure senza la possibilità di verificare “effetti ipodermici”, che l’influenza esercitata dai media non può essere negata.
A quanti, in buona o mala fede, mettono in dubbio il potere della Tv, ha risposto sbrigativamente, ma con indubbia efficacia, il deputato democratico dello Stato di New York, Charles E. Schumer, nel corso delle udienze sulla Tv da lui presiedute nel dicembre 1992: «Se la televisione non ha alcun effetto sugli spettatori, come si spiegano i miliardi di dollari spesi ogni anno in pubblicità televisiva?».
Ed è la pubblicità che, al di là dei suoi “effetti collaterali” – dal momento che non incide solamente sul piano commerciale – costituisce l’autentico motore dei media e, in particolare del sistema televisivo. Si tratta, infatti, della fonte di finanziamento, totale o parziale, di tutta l’emittenza, se si esclude il caso unico della BBC. Con conseguenze che investono negativamente, come si è visto, il quadro complessivo della programmazione
Oltre a costituire un autentico ingombro nel tessuto delle trasmissioni, interrompendole in continuazione con modalità non sempre corrette e comunque sempre fastidiose, la pubblicità rappresenta una spinta continua, inesorabile, alla conquista dell’ascolto. Agli inserzionisti non interessa più di tanto la qualità delle trasmissioni, interessa sopra ogni altra cosa la loro capacità di attirare audience, l’entità dell’ascolto, il numero di persone da raggiungere e da condizionare. E gli ingredienti per ottenere tale risultato non sono certo l’invito alla riflessione, la pacatezza, l’equilibrio, bensì il richiamo ad ogni costo, fino allo scandalo.
Dal canto loro le emittenti puntano a massimizzare i profitti con implacabile avidità, assecondando tale disegno. E’ la stessa ingordigia che ha spinto la Rai a inserire, nella trasmissione di Capodanno 2916 su Raiuno, una fascia scorrevole dedicata – a pagamento – ai messaggi dei telespettatori, tra i quali è finita anche una bestemmia.
Va dove ti porta l’auditel
La misura del “valore” di qualsiasi programma televisivo, in un sistema parzialmente o totalmente commerciale, è dunque la capacità di produrre audience. E’ sempre attualissima l’affermazione di un produttore televisivo americano che già molti anni fa confessava senza esitazioni: “noi non produciamo programmi, produciamo “teste” per gli inserzionisti pubblicitari”.
La conquista dell’audience costituisce una vera e propria ossessione per quanti lavorano nell’ambito televisivo e le misurazioni dell’Auditel, pur con tutti i problemi di credibilità che le riguardano, costituiscono il metro di valutazione corrente delle trasmissioni. Quanti programmi sono stati tolti dalla circolazione per l’inadeguatezza quantitativa degli ascolti. Certo, la valutazione qualitativa è molto più difficile di quella rozzamente quantitativa. Ma è una valutazione possibile, e gli sforzi della Rai per utilizzare criteri qualitativi per le sue trasmissioni vanno in tal senso. Ma la vera battaglia quotidiana si combatte sul fronte dell’audience perché è la sua entità che determina gli introiti pubblicitari, inesorabilmente condizionati dal fattore numerico.
La pubblicità ha come fattore di guida quello quantitativo, la massimizzazione dei contatti, e al dato quantitativo corrispondono le tariffe pagate dagli inserzionisti. La rincorsa al dato numerico si fa così ossessiva e gli autori e i protagonisti dei programmi sono costretti a fare ricorso a qualsiasi espediente capace di attirare l’attenzione e a mantenerla sempre ai massimi livelli possibili. Con ricadute qualitative che si traducono nel ricorso ai più vieti espedienti di richiamo, dalla violenza alla volgarità.
Ne consegue una dimensione essenzialmente commerciale del sistema televisivo, dovuta non solo alla quantità dei messaggi commerciali trasmessi e neppure alle modalità insidiose del loro inserimento tra e nei programmi, ma anche alla tendenza della programmazione a ubbidire a finalità di cattura dell’audience, sulla base di contenuti di alto richiamo emotivo, che fanno leva, come si è detto, sulla violenza, sulla sessualità, sul pettegolezzo, sulle risse.
Momento cruciale nell’affermazione del modello televisivo condizionato dalla pubblicità è stata la vera e propria rivoluzione televisiva avvenuta tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso. Qualcuno ha parlato di “neotelevisione” per definire il nuovo corso della programmazione, caratterizzata da un flusso continuo in cui i generi si sovrappongono e si confondono, mentre i valori commerciali e l’ideologia del consumo pervadono i palinsesti. Dalla concezione pedagogica e paternalistica delle origini, si è passati a una concezione esasperatamente commerciale. Un passaggio legato alla nascita e all’impetuoso sviluppo dell’emittenza privata, che purtroppo ha finito per coinvolgere la Rai, incautamente lanciata in una lotta concorrenziale fatalmente destinata a minare le basi stesse del servizio pubblico.
Caratteristica del nuovo corso è l’intreccio tra programmazione e pubblicità, in sintesi una radicale invasione pubblicitaria delle trasmissioni televisive che oltre alla smodata dimensione quantitativa si caratterizza anche per l’adozione di modalità occulte o semi-occulte. Basterebbe pensare al cosiddetto product placement, l’inserimento di immagini di prodotti nel contesto di un programma, per delineare il crescente inquinamento pubblicitario della televisione (come di altri media). Considerato in passato come forma di pubblicità ingannevole (“inganno sottile” l’aveva definito l’Autorità antitrust), è stato legittimato in sede europea e ora viene proposto tranquillamente dovunque fa comodo, a dimostrare come la forza del profitto finisce per prevalere su ogni forma di tutela dei cittadini. Siamo di fronte, in realtà, a un progressivo annacquamento delle norme poste a tutela dei telespettatori che ha coinvolto anche la durata degli intervalli tra interruzioni pubblicitarie e la disciplina delle telepromozioni sottratte, come le sponsorizzazioni, alle restrizioni quantitative stabilite per gli spot.
Nelle ore di punta dell’ascolto televisivo (“prime time”) sulle reti commerciali le forme “evidenti” di pubblicità (spot, telepromozioni, trailer, promo) superano complessivamente, ormai da tempo, il 20% della programmazione. A questa invasione (“affollamento”) consentita dalle leggi in vigore, ma spesso superata nei fatti, si aggiungono le forme più o meno clandestine di pubblicità. Gli interventi sanzionatori si sono rivelati poco tempestivi, poco incisivi, sostanzialmente inefficaci: quando la sanzione arriva, si rivela sempre inadeguata rispetto al vantaggio derivante dalla violazione delle norme.
Si può dire, ormai, che la storia della televisione è, praticamente, la storia della crescente invasione pubblicitaria dei programmi e del condizionamento che esercita su di essi. E’ questo condizionamento che viene ignorato nelle discussioni sulla riforma del sistema televisivo, legato a filo doppio al valore del dato quantitativo, per cui una trasmissione vale in rapporto al numero dei telespettatori ottenuto, unico metro di valutazione della “qualità”.
Ho già utilizzato in passato, a tale riguardo, il proverbio “chi paga l’orchestra sceglie la musica”, sul quale occorre riflettere seriamente in sede di revisione del sistema televisivo. Si tratta di una riflessione resa difficile dall’enormità degli interessi in gioco, naturalmente ignorata dall’informazione diffusa attraverso le trasmissioni televisive.
L’audience, vale a dire l’insieme delle persone che vedono un programma, è “la vera merce” venduta dalle televisioni agli investitori pubblicitari. E l’Auditel è lo strumento di questo mercimonio, utilizzato spregiudicatamente per definire la funzione fondamentale del servizio televisivo. E’ la caccia all’ascolto, al numero, al dato quantitativo che produce trasmissioni in cui anche gli insulti, le risse e perfino le bestemmie (si pensi a certi reality show), sono “incidenti” provocati ad arte per mantenere i “contatti”.
Il numero, non importa come ottenuto, è l’unico metro di valutazione della realtà televisiva. Ma il numero può ritorcersi anche contro chi lo promuove, se si considerano le conseguenze dello sviluppo quantitativo della pubblicità Tv.
La dimensione quantitativa
Nel corso del 2014 Rai, Mediaset e Sky hanno mandato in onda 155 milioni di secondi di pubblicità (8 volte in più del 2010) . Gli spot trasmessi durante l’anno sono stati oltre 7 milioni 377 mila. Dunque la dimensione quantitativa della pubblicità televisiva è enorme. Ha scritto in proposito Aldo Fontanarosa: «Stavolta le televisioni hanno rotto il muro del suono. Hanno infranto ogni argine, hanno esagerato come mai prima» . I dati li ha forniti la Nielsen, società specializzata in ricerche di mercato.
Alcuni anni fa uno studio di Lucia Canzi e Michele Covati, svolto in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, aveva delineato il quadro della regolamentazione della pubblicità in televisione arrivando alla conclusione che “l’ingombro pubblicitario” oltre ad essere “ingente”, era anche “al di fuori dei limiti disposti dalla legge”.
Tale studio, durato 11 mesi (da settembre 2005 a luglio 2006), era rivolto a «quantificare l’ingombro pubblicitario» e a «verificare l’inserimento dei messaggi pubblicitari all’interno di particolari programmi» e non ha preso in considerazione, di proposito, le trasmissioni di fiction, limitandosi a considerare «la presenza e la durata di minispot all’interno di manifestazioni sportive, la presenza e l’entità della pubblicità durante i programmi di cartoni animati e la presenza di pubblicità di alcolici e superalcolici in fascia protetta o nelle vicinanze di programmi rivolti ai minori». Tuttavia ha fornito i dati riguardanti la quantità di messaggi pubblicitari proposti ogni giorno ai telespettatori, giudicata come uno dei punti critici della programmazione televisiva. Le percentuali di tempo dedicato alla pubblicità vanno dal 5%, 8% e 10% rispettivamente per RaiTre, RaiDue e RaiUno, al 24% per tutte e tre le reti Mediaset. A … metà strada La7, con il 19%. Media complessiva: 16%.
A fronte di una percentuale di programmazione dedicata alla pubblicità così elevata, gli autori dello studio si sono domandati se i limiti di affollamento pubblicitario stabiliti dalla legge siano rispettati. E la risposta è stata altrettanto chiara: nessuno sforamento giornaliero, nel periodo esaminato (tra il 7 settembre 2005 e l’8 luglio 2006), per RaiTre e RaiDue, due soli sforamenti per RaiUno, 40, 44 e 45 gli sforamenti delle tre reti Mediaset le quali «hanno violato sistematicamente i limiti orari stabiliti per legge».
I limiti stabiliti attualmente dal testo Unico per la Radiotelevisione sono i seguenti: – 12% della programmazione per la concessionaria pubblica – 18% della programmazione per le concessionarie private La legge, tuttavia, prevede una possibilità di sforamento per un massimo del 2%, da recuperare nell’ora precedente o in quella successiva.
Troviamo però un’autentica ciliegina sulla torta (pubblicitaria): i limiti di affollamento pubblicitario riguardano solo gli spot e, quindi, dal calcolo sono escluse tutte le altre forme di pubblicità come televendite, telepromozioni e spazi dedicati agli sponsor. C’è anche da rilevare che ai limiti quantitativi, a dir poco “generosi”, corrisponde poi una debolezza sanzionatoria nei confronti di chi, comunque, li infrange. Nel 2007 Martin Seylmar, portavoce del commissario europeo alle telecomunicazioni, Viviane Reding, preannunciando l’invio all’Italia di una procedura di infrazione per l’eccessivo numero di spot delle emittenti televisive, giudicato “inaccettabile”, poneva in risalto anche la strana esclusione delle televendite dai calcoli dei tempi pubblicitari.
Come si vede, la legislazione in materia televisiva è fortemente contrassegnata da un “favore pubblicitario” per l’emittenza, che si traduce in un pesante svantaggio per i telespettatori, aggravato, oltre che dai problemi di quantità, anche da quelli dei contenuti pubblicitari. In definitiva, una lettura attenta della legislazione in materia radiotelevisiva rivela, anche sotto il profilo degli inserimenti pubblicitari, l’influenza che su di essa hanno esercitato le potenti lobby del settore e, in particolare, il peso della forza politica legata alla proprietà del più grande gruppo televisivo privato.
Di fronte alla proliferazione selvaggia della pubblicità vale la pena di ricordare che già trent’anni fa la rivista “l’Editore”, pubblicata (da tempo non esce più) da Gutenberg 2000, aveva dedicato l’editoriale alla “marmellata di spot”, colpevole di ridurre l’efficacia della pubblicità televisiva oltre che – si deve aggiungere – di penalizzare la raccolta pubblicitaria della carta stampata. Vale anzitutto la pena di rileggere l’incipit di quell’editoriale:
”Il problema – è stato detto recentemente – non è solo quello di salvarsi dalla pubblicità, ma anche quello di salvare la pubblicità”. Le tante denunce sull’eccessivo volume di pubblicità che dagli schermi televisivi si riversa sui telespettatori si erano scontrate finora con l’ottimismo inattaccabile degli utenti pubblicitari e dei signori dell’etere. Entrambi allineati nell’affermare – come il dottor Pangloss di Voltaire – che quello della pubblicità televisiva italiana è il migliore dei mondi possibile. Ora, però, gli scricchiolii di un sistema che non rispetta alcuna regola e all’interno del quale la concorrenza ha prodotto un allineamento al basso, si sono fatti troppo evidenti perché si possa continuare ad ignorarli.
A suffragio della denuncia veniva citato, anzitutto, uno studio dell’agenzia pubblicitaria Testa dal quale emergevano due affermazioni importanti: 1) l’efficacia di ogni campagna pubblicitaria è inversamente proporzionale all’affollamento pubblicitario complessivo; 2) in mezzo a tanto baccano pubblicitario occorre gridare e gridare forte per farsi sentire. Con la conseguenza che gli ingenti investimenti pubblicitari finiscono per andare praticamente in fumo. In secondo luogo veniva dato spazio alle conclusioni di un convegno organizzato a Roma sul tema “La qualità della pubblicità Tv” da Sacis e Sipra, le consociate Rai incaricate di occuparsi della pubblicità e oggi riassorbite dalla capogruppo, competenti, rispettivamente, nel controllo dei contenuti e nella raccolta delle inserzioni per i canali radiotelevisivi del servizio pubblico e per altri media. Scriveva in proposito “l’Editore”:
«Anche qui, dove si sarebbe dovuto parlare di qualità, l’incubo che ha finito per dominare i lavori è stato quello della quantità, dell’”effetto marmellata” determinato dal numero dei messaggi, ognuno dei quali finisce per perdere la propria identità e mescolarsi in un confuso ed indistinto turbinio di suoni, immagini e slogan che spesso induce i telespettatori a cambiare canale, quasi sempre li infastidisce e raramente consente al singolo messaggio di esercitare una effettiva pressione pubblicitaria».
Nel corso del convegno, il celebre pubblicitario francese Jacques Séguéla non usò mezzi termini e proclamò: “Troppa pubblicità uccide la pubblicità”. E tuttavia non accadde nulla e la situazione odierna è persino peggiore di quella di allora. Le stesse televisioni a pagamento, nate per evitare le intrusioni pubblicitarie, hanno cominciato a farcire le loro trasmissioni con spot d’ogni tipo, fino a inserire anche fastidiosissime sovrapposizioni pubblicitarie in ogni genere di programma.
Gli eccessi quantitativi, come appare evidente, finiscono per penalizzare la stessa pubblicità, e tuttavia nessuno osa mettere in discussione seriamente il fenomeno, dal momento che la pubblicità ha ormai assunto un potere enorme nel sistema dei media. E tuttavia il dilagare della pubblicità televisiva danneggia persino chi la paga, dal momento che affoga gli spot in un marmellata indigeribile e, per restare al tema di questo scritto, condiziona pesantemente, riducendola al peggio, l’intera programmazione.
Quale riforma
Alla fine del 2015 il Parlamento ha partorito, come si è detto, una nuova riforma della Rai. Un provvedimento molto criticato, dal momento che non è in grado di dare la necessaria autonomia all’azienda pubblica rispetto al governo e ai partiti.
Come aveva anticipato Vittorio Emiliani – che di televisione se ne intende, essendo stato conduttore di programmi e consigliere di amministrazione della Rai dal 1998 al 2002, – questa “riforma” mantiene la Rai «nelle mani clientelari dei partiti e della presidenza del Consiglio, la quale nomina il presidente, un consigliere e il super amministratore unico». E mentre la Rai non viene sottratta al controllo politico, restano a carico dell’emittenza televisiva nel suo insieme l’ingombrante conflitto di interessi di cui si è detto e il condizionamento sulla programmazione esercitato inesorabilmente dalla pubblicità. Ed è proprio questo condizionamento che mantiene intatta l’anomalia dell’emittenza televisiva a dispetto della solenne proclamazione contenuta nella vigente legge di sistema (la “Legge Gasparri” poi diventata “ Testo Unico della radiotelevisione”) all’art. 3, che proclama i “Principi fondamentali” del sistema radiotelevisivo italiano, che vale la pena di rileggere:
Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.(Articolo così modificato dall’art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44).
Parole al vento è, purtroppo, il caso di dire, per non parlare, poi, di quelle che la legge dedica ai “Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti” (art. 4), a “salvaguardia del pluralismo e della concorrenza” (art. 5), ai “Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo” (art. 7).
Per consentire al mezzo televisivo di essere strumento di promozione civile e culturale, non bastano le belle proclamazioni di principio: è necessario garantire anche “tecnicamente” la correttezza dell’informazione, impedendo ingerenze politiche e risolvendo conflitti di interesse; e, più in generale, sottraendo tutta l’emittenza ai condizionamenti che l’intera programmazione subisce a causa della dittatura pubblicitaria.
Proprio l’autore dell’infelice legge di sistema oggi in vigore, il senatore Maurizio Gasparri, in occasione di una delle tante polemiche suscitate dalla volgarità dei cosiddetti “reality show”, che sono solamente l’iceberg della poltiglia televisiva, si è espresso in proposito con estrema chiarezza, come ha riferito Emilia Costantini sul “Corriere della Sera”: «Avranno tanto successo. E questo dovrebbe essere motivo di riflessione autocritica per tutti, ma questi reality sono ormai la pattumiera della televisione. Dopo il pessimo contributo della Raidue di Marano – continua – ora è la stagione del Grande fratello Mediaset Endemol. Si fa clamore ad ogni costo e si lanciano messaggi sempre peggiori. Il perdurante successo di queste trasmissioni spazzatura – insiste Gasparri – e l’inutilità delle critiche che a esse sono rivolte, non fanno venire meno il dovere di immaginare risposte di tipo economico a tv pubbliche e private così diseducative». E pensare che, solo qualche giorno fa, il premier Silvio Berlusconi, ammettendo di aver visto la prima puntata del reality di Canale 5, aveva definito il Grande fratello “sempre interessante e magnetico”».
Il riferimento a “risposte di tipo economico” rimanda immediatamente a ciò che si è detto a proposito dell’influenza nefasta esercitata dal condizionamento pubblicitario della programmazione. E aiuta a concludere che nessuna riforma del sistema televisivo potrà sottrarlo all’attuale imbarbarimento senza una chiara limitazione del peso che la caccia all’audience opera oggi in modo implacabile. Non si tratta certo di demonizzare la pubblicità o di negare la sua positiva funzione economica, ma di impedire che il suo ruolo di finanziamento dell’emittenza possa condizionare oltremodo i contenuti dei programmi. In quanto attività economica, è bene ricordarlo, la pubblicità è disciplinata dall’art. 41 della Costituzione, secondo il quale tale attività «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
Risultano eloquenti in proposito le parole pronunciate dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’intervento al Parlamento, già ricordato, sulla possibilità di “risollevare la qualità delle trasmissioni televisive”: «fin quando le trasmissioni sono dominate dall’assillo di ricavi pubblicitari e questi sono connessi esclusivamente all’audience, i tentativi saranno inefficaci. I pubblicitari infatti sono convinti che quanto più si abbassa il livello di una trasmissione tanto più ampia è l’audience. Si innesca così una spirale perversa che diseduca il gusto dei telespettatori e degrada il livello delle trasmissioni».
Sciogliere il nodo della pubblicità, della sua influenza sulla programmazione, appare un problema ineludibile in qualsiasi tentativo serio di riforma del sistema televisivo.