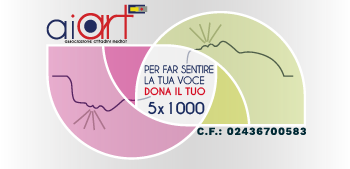Il pericolo di esaltare la violenza e la devianza
Il successo delle serie televisive Romanzo Criminale e Gomorra. Nel caso delle fiction italiane, i fenomeni criminali hanno cause e caratteristiche diverse da quelli descritte nelle opere americane. Quali gli effetti sui giovani di una rappresentazione romanzata, a volte romantica dell’universo criminale? Di Gianluca Arnone
Il proliferare sulle reti televisive italiane, a pagamento e non, di fiction ambientate nel mondo della criminalità organizzata – Romanzo Criminale e Gomorra – La serie certo, ma ci sono stati anche prodotti meno eccellenti come Pupetta – Il coraggio e la passione – ha certificato il tentativo tardivo ma necessario del nostro sistema audiovisivo (grazie soprattutto all’impulso delle pay) di recuperare terreno nei confronti dei grandi network americani, puntando su format, storie e linguaggi dal respiro internazionale.
In effetti dobbiamo riconoscere che uno svecchiamento c’è stato. Nei codici espressivi, per l’attenzione maggiore all’uso retorico delle luci, una scrittura dei dialoghi più aderente alla realtà, un’intensificazione della messa in scena, più in linea con la comunicazione sintetica, smaliziata e veloce di oggi. E nei modelli narrativi, dove si è puntato con decisione a una riqualificazione dei generi nel sistema audiovisivo italiano – la crime story è l’esempio più lampante di un orizzonte sempre meno appiattito sul macro-filone familiare stile RAI, della commedia e della biografia – e una problematizzazione maggiore del dato di realtà: la crime story ha una cornice più tetra, un’attrazione per le zone d’ombra morali, un’abitudine a umanizzare il negativo, il fuorilegge, il criminale.
Il tentativo nemmeno troppo nascosto è di stanare un target più giovane, messo un po’ ai margini dalla tv generalista o comunque disinteressato alla loro offerta. Sul mercato il coinvolgimento dei giovani è più allettante di quello dei pensionati, per il semplice fatto che i primi consumano mediamente di più dei secondi. Eppure le storie che raccontano le serie tv del momento richiedono senza dubbio una partecipazione emotiva maggiore e, quindi, una maggiore attenzione a livello cognitivo per decifrare, anche dal punto di vista etico, il mondo offerto dalla rappresentazione.
C’è nei più giovani questa capacità? Sanno loro che non c’è mai una rappresentazione ingenua, che la cosiddetta storia più vera del vero è solo un artificio più raffinato dell’arte della simulazione? In fondo cos’è Gomorra fuori dal circuito editoriale/cinematografico/televisivo? Esiste effettivamente là fuori, nel modo in cui abbiamo imparato a conoscerla attraverso l’industria culturale? E qualora ci fosse qualcosa di molto vicino a quella cosa che chiamiamo “Gomorra”, quanto influenzerebbe il nostro status di lettori e spettatori sulla percezione del fenomeno? Le condizioni di fruizione, caratterizzate normalmente da una situazione di comfort e di assenza di pericolo, non alterano l’oggetto di cui si fruisce? E per finire, l’entusiasmo per una rinascita al momento solo auspicata di una serialità all’italiana non rischia di mettere in secondo piano la questione educativa, ovvero il problema di quali siano gli effetti sui minori di una rappresentazione romanzata, a tratti addirittura romantica, dell’universo criminale?
Nell’inoltrarci in una discussione non certo nuova, occorre fare due premesse di carattere generale. La prima è che non esiste né è mai esistita alcuna corrispondenza comprovata tra modelli valoriali della finzione e modelli valoriali degli spettatori. Nessuna interferenza diretta sulle credenze e i comportamenti. Nessun riflesso condizionato, nessuno schema stimolo/risposta. Chi afferma il contrario mente sapendo di mentire. Tutta la seconda metà del Novecento è stata segnata da diversi studi di carattere sociologico sui presunti effetti diretti dei media nell’audience e oggi tutti tendono ad escludere dinamiche di imitazione così rozze e potenti da immaginare un “lavaggio del cervello” del pubblico. Continuare a sostenere il contrario significa demonizzare il mezzo, ovvero assumere una posizione a-scientifica, ideologica, dalle argomentazioni speciose.
La dinamica degli effetti è invece molto più complessa, imprevedibile, condizionata da diversi fattori, di cui il contenuto del messaggio e lo stile comunicativo sono solo una parte, non per forza la più importante. La seconda premessa riguarda l’intenzionalità dei messaggi: non necessariamente chi produce e veicola contenuti vuole inoculare qualcosa nella testa del pubblico.
Prendiamo il caso delle due serie tv di cui sopra, Romanzo criminale e Gomorra. Entrambe, più che preoccuparsi delle storie che veicolano (quelle d’altra parte le hanno fornite i romanzi da cui sono tratte) si concentrano sul modo in cui veicolarle. Stefano Sollima, figlio del grande Sergio e regista di entrambe le operazioni, ha cercato soprattutto di adottare, più che adattare, archetipi e stilemi del gangster-movie americano. Puntando tutto sulla resa spettacolare piuttosto che su una vera contestualizzazione, sul ritmo invece della messa in questione di scelte di vita violenta, di confini morali labilissimi e di tutto quanto va a solleticare il tribunale della coscienza.
Questo puro e semplice prendere in prestito un modo di raccontare all’americana, senza mediazioni né ripensamenti è il vero limite di Romanzo criminale e Gomorra. Più che considerarle pericolose andrebbero giudicate deficitarie: non basta l’emulazione di una gloriosa tradizione narrativa a garantire la resa. Si percepisce la messa in moto di un meccanismo drammaturgico oleato ma non se ne vede né la testa né i piedi. In fondo l’aspetto romanzato, quasi mitico, di vite votate all’illegalità e all’annichilimento proprio e altrui di cui vi è traccia tanto nella banda della Magliana raccontata da Romanzo criminale quanto nello Stato che vediamo all’opera nella Napoli di Gomorra, è una ripresa delle grandi epopee criminali raccontate dal gangster-movie hollywoodiano, da Il padrino a Quei bravi ragazzi, da Scarface a Gli intoccabili, senza però la loro cornice originaria, il contesto storico e sociologico nel quale e grazie al quale queste vicende sanguinarie hanno assunto la forma mitica delle epopee. Non va dimenticato infatti che le comunità italoamericane subivano profondamente la fascinazione per determinati personaggi a motivo del loro essere un modello, sia pure discutibile, di riscatto sociale.
Da una condizione di marginalità sociale al successo in campo economico e al potere d’influenza politica: il gangster italoamericano (o portoricano o irlandese, la dinamica è riscontrabile in molti altri gruppi etnici) finisce per incarnare il Sogno Americano sia pure nelle forme della devianza e della violenza. Non va dimenticato poi che il gangster-movie è un’evoluzione urbana del western, il genere che prima di ogni altro ha mitizzato un mondo senza regole, violento e pericoloso, dove lo status di fuorilegge non è ancora aberrante e il suo significato non ha accezione negativa. Quante volte il pistolero senza nome (dunque, senza legge) è anche l’eroe di queste storie, il cuore vivo e generoso di una comunità in costruzione? Peccato che tutto questo immaginario imbevuto di ragioni storiche e politiche, economiche e sociologiche, non valga nel caso italiano, dove i fenomeni criminali hanno cause e caratteristiche diverse. Sarebbe bello se i nostri film e le nostre serie televisive ne tenessero conto. Dimostrare di conoscere un po’ di storia e scavare più a fondo nelle “ragioni” della malavita organizzata in Italia restituirebbe a queste produzioni una funzione educativa che al momento non hanno senza togliere nulla al loro mandato spettacolare.