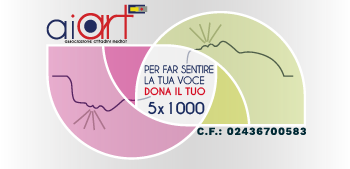Internet e il diritto all’oblìo: Google è giudice di se stesso

Dopo la sentenza di due anni fa della Corte di Giustizia Europea, inchiesta del New York Times che rivela: il motore di ricerca, su 418 mila richieste di cancellazione di contenuti, ne ha “accolte” soltanto la metà. E i tribunali non possono farci nulla. Di Federico Rampini dal sito de la Repubblica del 19 aprile 2016
NEW YORK – Tra l’Unione europea e Google è una sorta di guerra permanente. Dalle accuse di elusione fiscale, a quelle di abuso di posizione monopolistica, un contenzioso ampio oppone le autorità di Bruxelles al colosso californiano. Uno dei passaggi-chiave nell’escalation della tensione, fu la celebre sentenza della Corte di Giustizia europea (13 maggio 2014) sul “diritto all’oblìo”, che impose proprio a Google delle regole a tutela della privacy, ben diverse da quelle in vigore negli Stati Uniti. Ma oggi un’inchiesta del New York Times sostiene che quella sentenza non ha affatto ridimensionato Google. Al contrario, ha reso il gigante dell’economia digitale ancora più potente di prima. Google si sarebbe trasformato nel tribunale di fatto, che giudica l’ammissibilità delle richieste di cancellare questa o quella informazione dal cyber-spazio.
Per capire la conclusione a cui giunge oggi il New York Times, bisogna fare un passo indietro, e tornare a quella sentenza di due anni fa. Che affrontò il problema della “memoria che non scompare”. Una decisione per molti versi storica. Accolta con reazioni contrastanti, da una parte e dall’altra dell’Atlantico. Al centro della sentenza, c’è una questione di grande importanza, cioè la capacità di Internet di preservare per sempre qualsiasi informazione su di noi, anche se sbagliata ed eventualmente calunniosa. Oppure vera, ma comunque lesiva della reputazione.
Cosa stabilì la Corte di giustizia europea? Che abbiamo un “diritto all’oblìo, a essere dimenticati”, e che Google in particolare deve rispettarlo. La sentenza si applicava a Google in particolare, perché nasceva dal ricorso di un cittadino spagnolo che chiese la cancellazione di un link (ovvero “legame”: è la breve citazione che noi clicchiamo e ci porta al contenuto integrale). Quel link, dal motore di ricerca Google portava ad una condanna di bancarotta da lui subìta anni prima. L’importanza del pronunciamento dei giudici costituzionali è erga omnes: si applica a tutti, sul territorio dell’Unione europea. La Corte ha stabilito che se un cittadino lo chiede, Google deve togliere dal suo motore di ricerca dei contenuti dannosi o lesivi della sua reputazione. La Corte considera Google responsabile, anche se si limita a fornire dei link che portano a contenuti elaborati da altri: giornali, blog, archivi giudiziari, social network. Già prima di quella sentenza, Google riceveva in media cinque milioni di richieste a settimana, per la cancellazione di contenuti che sono protetti da copyright (esempio: brani musicali o film su YouTube). Ora deve vedersela con un altro genere di richieste: la cancellazione di notizie sgradite, calunniose o diffamanti sul nostro passato; fotografie che ci ritraggono in pose indecenti, insulti contro di noi sui social media, e così via.
La distanza tra Europa e Stati Uniti, in termini di cultura giuridica, è diventata ancora più ampia dopo questa sentenza. In America il Primo Emendamento della Costituzione protegge la libertà di espressione in un’accezione così estesa che non ha probabilmente eguali al mondo, cancellare contenuti da Internet è molto difficile.
Ma la rivoluzione europea, che sulla carta doveva imporre doveri a Google, si è trasformata in un boomerang. L’inchiesta del New York Times rivela che in questi due anni Google ha svolto il ruolo di un vero e proprio tribunale, esaminando 418.000 richieste di “oblìo e cancellazione”. Al ritmo di 572 al giorno. Ed è Google ad avere deciso, come un giudice, quali richieste approvare: meno della metà. La ragione di questa delega è facile da intuire: le authority nazionali sono oberate di lavoro, non parliamo dei tribunali. Dunque dopo aver preso una decisione “rivoluzionaria”, l’Europa si accontenta che sia Google a stabilirne l’applicazione, a decidere in quali casi le richieste sono legittime e in quali no. Google è diventato il giudice di se stesso, con la tacita tolleranza di quelli che dovevano imporgli limiti e doveri.