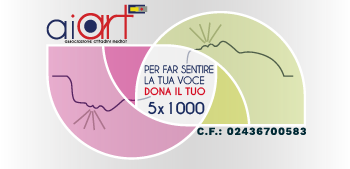Narrazioni social-mediali: tante facce della violenza

Non è possibile rimanere indifferenti rispetto ai fatti, ma soprattutto alle narrazioni di queste giornate. E neppure lasciar scorrere senza interrogarsi leggendo i titoli di alcune testate:
PEGGIO MORTI CHE BENDATI (cosa si vuol far passare…); – Un killer di Roma interrogato bendato. CHE PESSIMA FIGURA (la figura è l’aspetto esteriore di una cosa o di una situazione: la preoccupazione è per il modo di apparire. Ma non è questo il punto); LA VERGOGNA E IL DOLORE (qui si antepone la vergogna al dolore, anche nella posizione delle fotografie: sopra la foto del giovane americano e, sotto, la foto del feretro); – BENDA ALL’AMERICANO. INCHIESTA A RISCHIO (scorrendo la pagina, si nota l’ effetto decontestualizzante fra titolo e foto con il bagno di folla accorsa per l’ultimo saluto al giovane carabiniere); – UNA BENDA E UNDICI COLTELLATE ( in questo accostamento scompare del tutto l’umano, una sintesi densa di crudezza, “secca come un ramo”: banalizza una realtà che chiede di essere presa in carico in tutta la sua tragica complessità).
Poi lo sguardo si apre sullo scenario attuale in cui le notizie vanno a impattare:
Legittima difesa.
Punire i soccorritori che intervengono nelle condizioni di pericolo in mare.
Inasprire le pene.
Evocare la pena di morte.
Ne esce un climax. Un crescendo di provvedimenti ed esternazioni che, in nome della sicurezza nazionale, fa sentire poco sicura la vita disegnata dalla nostra Costituzione. Un crescendo che, amplificato, esasperato, deformato nell’arena dei social, diventa un’onda incontrollata di odio allo stato puro – da una parte e dall’altra degli schieramenti politici. Sì, perché l’odio non ha colore: è cecità. L’odio oscura l’umanità, la razionalità, la dignità, la speranza, l’attenzione e la cura per chi è in difficoltà; l’odio non riconosce la comprensione, l’empatia, il rispetto, la reciprocità, la diversità, ma, soprattutto, non riconosce l’amore nella sua accezione di quell’alfa privativo che significa “togliere dalla morte”. E la cultura della morte affonda tutti.
D’altra parte un mondo giornalistico che si nutre, ahimè, anche di queste derive. È bastata una foto – con tutte le emozioni che provoca, lo sconcerto che imprime e gli interrogativi che apre – a far diventare il giorno dei funerali di un giovane carabiniere massacrato da chi giovane lo era appena diventato, un giorno di bagarre, di diverbio collettivo, di esternazioni divisive e, spesso, inaccettabili. Forse erano questi – e questo in particolare – i giorni del silenzio, del silenzio assordante del dolore, di quel silenzio che poteva dar vita a un sussulto di umanità che pare stiamo lasciando naufragare negli abissi dell’indifferenza. Forse stava bene proprio la parola “silenzio”, con quella radice “si” che si rifà all’atto di legare. Legare le parole alla calma, allo spazio di una riflessione profonda sulla vita di chi credeva nel proprio lavoro, nella famiglia, negli ultimi. Ma il diritto – dovere di trasparenza dell’informazione ha cavalcato l’onda dello scoop di una foto shock che, nella fretta del diffondere, crea un altro shock, che è il corto circuito etico tra tempo e ricerca della verità dei fatti. Nella scelta, il sopravvento della tempestività della notizia a scapito della preventiva informazione su quale racconto ci fosse dietro a quello scatto, della possibilità di consentire agli interessati il diritto di replica prima della divulgazione della foto al grande pubblico. Era la distanza di tempo che avrebbe consentito di silenziarsi e dare l’addio con lacrime, rispetto e riconoscenza a un concittadino, un rappresentante dello Stato che credeva nel servizio alle istituzioni e alle persone; era la distanza che consentiva di dar senso coralmente a quella solidarietà sociale che egli, nella sua breve vita, ha testimoniato. Attendere qualche giorno per accendere i riflettori sull’effettivo interesse alla diffusione dell’immagine per ragioni di tutela dei diritti e delle libertà altrui: era anche questo, a mio modesto parere, un atto rispettoso e a garanzia del diritto-dovere di cronaca.
Infine, l’accostamento tra i due fatti collegati ma ben distinti, ha portato alla scelta dei giornalisti di tener unite due narrazioni di cui solo una è un fatto, l’altra attende un profondo e responsabile chiarimento lontano dalle manipolazioni e dalla gogna mediatica, lontano dall’essere lesivo per un tessuto sociale già messo alla prova.
Tante sono le storie che chiedono un ripensare a come siamo e a come funzioniamo nell’informazione da produttori e da fruitori, anche attraverso e nei social media.
Diversi gli aspetti della violenza che chiedono di essere identificati: la violenza e la ferocia di un omicidio; la violenza insita nella disumanizzazione propria della droga; la violenza psicologica degli abusi; la violenza di far circolare foto prima ancora di capire cosa stia accadendo; la violenza morale di occupare la scena mediatica pur di fronte alla morte violenta, assurda, inaspettata che chiede la cura dello spazio del racconto, di scegliere la delicatezza nell’esercizio del diritto di parola e di informazione.
Il rischio è trovarci a dire “ciò che non siamo e ciò che non vogliamo”.
“Non domandarci la formula che possa renderti limpida l’esistenza,
bensì qualche sillaba mal pronunciata e secca come un ramo.
Questo soltanto oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”.
(E. Montale)
Sandra Costa Bona, vicepresidente nazionale Aiart (Associazione cittadini mediali)